Waldemaro Morgese, Sciamani, arabe fenici, banane gialle e mambo
Posted on: 12/09/2021

Waldemaro Morgese, Sciamani, arabe fenici, banane gialle e mambo
Giazira scritture, Noicattaro 2021
di Mary Sellani
Quest’ultima pubblicazione di Waldemaro Morgese, scrittore, saggista ed editorialista, composta da venticinque capitoli, è una raccolta di ricordi rievocati in forma di racconti brevi e nascenti prevalentemente da memorie di libri letti in grandissima quantità. In possesso di questa enorme erudizione, l’autore si diverte talvolta a metterla a disposizione anche della fiction. Ne scaturisce un’operazione in cui egli cita puntualmente autori noti e meno noti che sollecitano le sue riflessioni sulla vita, sulla società, su problemi morali o ideali e sul valore della conoscenza e della cultura. Ripercorrendo la lettura di libri con tale facilità, sembra quasi che egli non ami vivere la propria vita, ma la vita ‘già vissuta’, ricalcando orme che sono già state calcate: citando, ripetendo, riscrivendo, fondendo il presente con il passato.
Ecco allora che, attraverso le letterature del mondo, egli si cimenta con la propria scrittura in una regione più ampia della realtà nella quale è immerso, vivendo un’esistenza non personale ma puramente psicologica, e finendo così per percorrere l’universo. Aggiungendo poi un pizzico di mitologia alle storie lette, la realtà da lui descritta diventa più scintillante, piena d’incanti e seduzioni, misteriosa e contradditoria nell’alternarsi perenne tra la luce il buio. Si intuisce così, tra le letture di volta in volta scelte per la stesura dei suoi racconti, ciò che più soddisfa la sua immaginazione: il viaggio, la fuga, la metamorfosi, il naufragio, la recitazione, la menzogna, la fine di un’amicizia, il rifiuto della prassi, la fiducia nella tecnica, la refrattarietà al conformismo, la nostalgia del passato e l’attrazione per il nuovo. Ma la parte più riflessiva della sua mente lo porta anche a riconoscere che crescendo intellettualmente ci si accorge, per esempio, che il bene e il male non stanno tutti dalla stessa parte.
Lo si percepisce nel racconto Banane gialle, quando il protagonista, interpellando un amico dopo aver acquistato delle banane da un ambulante di strada, tra cui ve ne sono alcune marce, riflette: «Nella mia vita sono sempre stato a favore dei lavoratori e dei piccoli operatori economici. Le multinazionali e il grande commercio li odio. Ora cosa sta accadendo? Che ho mandato a quel paese un povero ambulante e mi sono ripromesso di cadere per sempre nelle fauci della grande distribuzione! È una catastrofe, i miei principi di una vita che fine hanno fatto?». La risposta dell’amico al suo dilemma è che «bisogna distinguere caso per caso, che non si può prendere una decisione per così dire ideologica, cioè a prescindere!». Non contento di questa spiegazione, egli rintraccia un libro dalla sua biblioteca, Terra nuova e buoi rossi di Emilio Sereni (1981) in cui l’autore ricostruisce l’antica pratica agricola del debbio, vale a dire rigenerare con il fuoco i terreni. Fatto sta che il racconto si conclude con la decisione del protagonista che d’ora in poi comprerà le banane anche dal diavolo, purché le possa mangiare con gusto. È l’evoluzione del mercato bellezza!, che vuol dire benefici per alcuni e sacrifici per altri.
Purtroppo, di paradossi e scomuniche di ideologie salvifiche è fatta la Storia del Novecento e in questa ambivalenza sembra muoversi tutto il libro di Morgese.

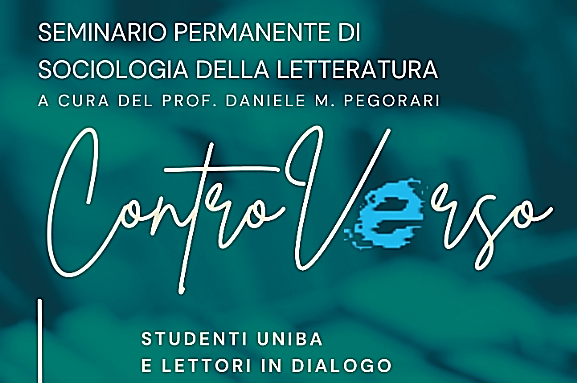
Lascia un commento